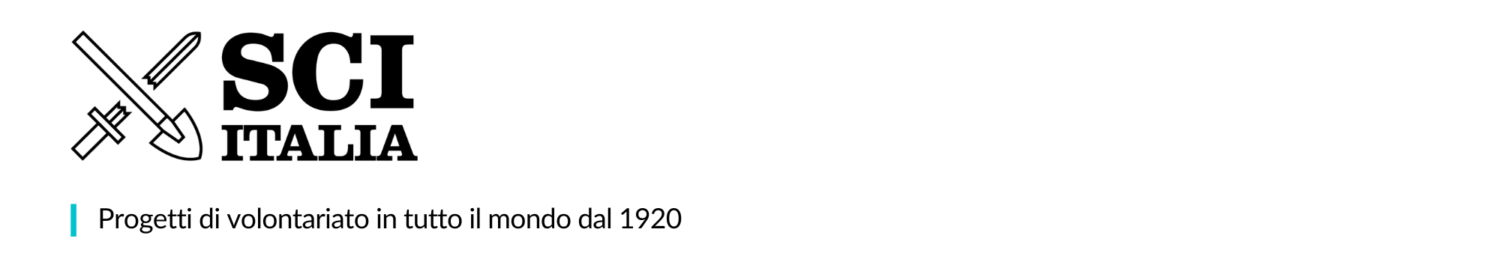“Ci vediamo tra cinque giorni”, aveva promesso il poliziotto all’ultima manifestazione. Si era spinto con la sua uniforme a un passo dal Presidio No Border di Ventimiglia insieme ai suoi colleghi, approfittando della ritirata di noi, attivisti ed immigrati, all’arrivo dei rinforzi.
Come ogni venerdì il presidio bloccava provocatoriamente il confine tra Italia e Francia, ballando e urlando “Hurria!” (“Libertà!”). Quel venerdì, in un’ora, si era formata una fila di macchine in attesa davanti alla dogana. Qualcuno si attaccava al clacson, ma per poco. Qualcuno diceva: “Convincimi che avete ragione!”. Solo una signora era scesa dall’auto per unirsi ai cori.
“State attenti, fanno come l’altra volta: arrivano con i manganelli”, premoniva una delle attiviste residenti nel campo da più tempo. Per evitare le botte già inferte avevamo per questo deciso di scappare verso il presidio, invece siamo stati inseguiti, minacciati, colpiti finché non abbiamo deciso di fermarci e formare un cordone che ribadiva: “We are not going back!”. L’autodifesa portava a raccogliere pietre, il collettivo convinceva ad alzare le braccia per dimostrare che non si stava commettendo nessun crimine. La libertà di movimento non può essere un delitto.
Dopo i cinque giorni promessi, celere e ruspe hanno sgombrato il presidio all’alba. I rifugiati sono tornati sugli scogli, come quando Ventimiglia ha iniziato a essere una notizia da prima pagina. Solo due settimane prima il presidio aveva lanciato l’appello: “Siamo più di trecento, ci servono abiti, cibo, aiuti!”. Per questo siamo partite in tre da Roma con mezza dozzina di scatole che gli attivisti avevano prontamente recapitato a La Città dell’Utopia.
Quando arriviamo, lo stanzone degli aiuti trasborda. “Basta vestiti!”, ci dicono. Da due settimane, è incessante il flusso di buste dirette ai rifugiati da parte della popolazione locale. Il presidio è un parcheggio occupato di un resort, a duecento metri circa dal cartello che indica “France” e sotto il cavalcavia dove passa il treno. L’orizzonte sbatte in faccia il paradosso di avere davanti Menton, la prima cittadina della Costa Azzurra. Palme e pensionati, oltre la frontiera. Un tempo e uno spazio sospesi, al presidio. Un luogo di passaggio costretto all’immobilismo.
Come potevano entrare 300 persone in un parcheggio? I rifugiati, prevalentemente sudanesi ed egiziani, non superano il centinaio al nostro arrivo. La lingua più diffusa è l’arabo, poi l’inglese, quasi nessuno parla italiano eppure questo non incide sulla capacità di capirsi. La musica suona incessante, dal vivo o dalle radio. Un’attivista racconta che “un gruppo di dervisci turchi che doveva esibirsi in Francia si è fermato da noi e ha improvvisato un concerto. La notte dopo è tornato e ci ha regalato metà degli incassi”.
Nel campo i volontari preparano le colazioni, piegano ed ordinano i vestiti, danno una mano. Il nucleo degli italiani è formato da liguri: “Ci sono sempre stati migranti qui. Abbiamo capito che si trattava di un flusso grosso quando la Protezione Civile ha portato i bagni chimici”, spiega Giannino. Ha fondato il presidio cento giorni fa e non si è mosso da allora. “Questo posto è ‘la bolla’ per me. Qui le regole imposte dall’Unione Europea non esistono”.
Lo strato più superficiale del presidio è quello del supporto materiale; c’è poi un altro strato, reticente a mostrarsi. Tra la Liguria e la Francia, si inerpica la sensazione di partecipare a una nuova resistenza. La dittatura è la frontiera; chi cerca di oltrepassarla è folle, illegale, da reprimere. Il confine misura la profonda distanza tra le parole “legalità” e “giustizia”.