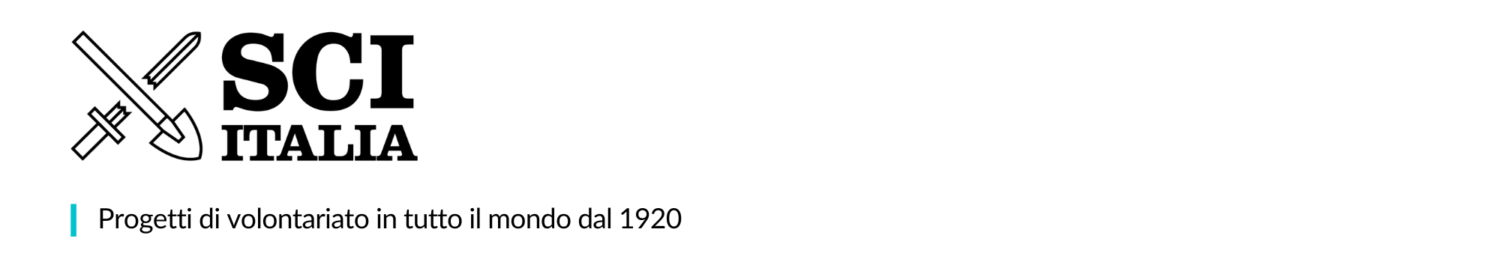Pubblichiamo la testimonianza di Anna Ferretti, volontaria partita lo scorso luglio 2017 per il campo “Conservazione ambientale, semina delle mangrovie e insegnamento delle lingue straniere” in Tanzania, presso le isole di Zanzibar.
Pubblichiamo la testimonianza di Anna Ferretti, volontaria partita lo scorso luglio 2017 per il campo “Conservazione ambientale, semina delle mangrovie e insegnamento delle lingue straniere” in Tanzania, presso le isole di Zanzibar.
Scrivere quest’articolo non è affatto facile come avrei pensato. Sono sempre stata molto affascinata dall’Africa e in effetti non so quanto Piero Angela abbia influito sulla cosa. Comunque finalmente sto andando e anzi, ahimè, sono già rientrata! Durante il volo di andata sono passata vicino al Kilimangiaro ed è stato strano, come avere la sensazione di tornare a casa. Anche se dovuta molto probabilmente all’auto-suggestione, è stata comunque un’emozione nuova e intensa.
Molte cose mi hanno affascinato di questa esperienza; tra le tante, una che ho sentito davvero mia sono stati gli esercizi della mattina. Io ho sempre amato lo sport e quando Harith, il coordinatore del campo, ci ha detto che prima dell’inizio delle attività, per chi voleva, c’era la possibilità di andare a fare esercizi ho subito colto la palla al balzo! Non avrei mai pensato di avere la forza per svegliarmi alle 6 meno 10 di mattina, e invece lì l’ho fatto.
Correndo la mattina vedevo il villaggio che si risvegliava, e quando entravo nello “stadio” c’erano sempre tantissimi ragazzi a fare esercizi. Correvano a piedi scalzi e correvano fortissimo. Quanto odio quando vengono a dire che in Africa un simbolo di povertà è il fatto che non hanno nemmeno le scarpe! Noi abbiamo bisogno delle scarpe per i nostri piedi molli e fragili. Che i bambini correvano senza scarpe è vero, ma questo non gli causava nessun problema. C’era una ragazza in particolare, avrà avuto tredici anni, che si allenava spesso in abiti tradizionali e, indovinate, senza scarpe. Sorrideva, si divertiva e anche senza tutti i nostri superflui comfort era un’atleta di alto livello. Anche gli altri ragazzi, tra cui i miei coordinatori, erano tutti molto forti e sciolti e si allenavano esattamente come si fa nelle migliori palestre – ma, piccola nota di colore, non avendo bilancieri bilanciati ogni dieci spinte cambiavano e giravano il bilanciere, in modo da fare esercizi equilibrati.
 Dopo la corsa raggiungevo sempre un gruppo di donne di mezza età che facevano esercizi tutte le mattine dalle 6 alle 7. Ho imparato a contare in swahili grazie a loro e anche se non capivo mi sono sentita accolta. Fortunatamente il linguaggio del corpo aiuta sempre molto in questi casi.
Dopo la corsa raggiungevo sempre un gruppo di donne di mezza età che facevano esercizi tutte le mattine dalle 6 alle 7. Ho imparato a contare in swahili grazie a loro e anche se non capivo mi sono sentita accolta. Fortunatamente il linguaggio del corpo aiuta sempre molto in questi casi.
Quello che mi ha fatto innamorare di questa esperienza è che qui ho trovato tutto il necessario e finalmente abbandonato il superfluo! Io, che sento di non essere libera perché vivo in una società piena di vincoli che comportano una sempre maggiore dipendenza dal denaro (non più soltanto per la sussistenza ma ormai anche ai fini dell’inclusione sociale), ho trovato qui il mio piccolo paradiso. Cibo, acqua e un tetto mi bastano. Quando uscivo in giro per il villaggio vedevo gente sorridente e serena. Il mio angolo di paradiso.
Ma questo paradiso ha il suo prezzo per chi ci è nato: la mancanza di futuro. Chi nasce in questo luogo non ha molte speranze di poter studiare e avere un qualche tipo di sicurezza economica: tutto dipende dalla famiglia. Molti ragazzi dell’associazione ospitante vedevano in noi un ponte per l’Europa, per un futuro diverso. Ed in fondo è vero, da noi puoi finire per strada ma la possibilità di un lavoro esiste, e allora il dilemma morale… ha senso fare un invito formale e farli venire in Italia? Il Paese che sputa in faccia a tutti i richiedenti asilo e dove la possibilità di non finire sfruttati è molto bassa?
Loro hanno la libertà; noi, forse, maggiori certezze economiche e lavorative. Il paradiso ora qual è?